 L’amazzone elvetica ha vinto oggi il Gran Premio in Spagna, gara che ha visto protagonista il cavaliere azzurro: entrambi in sella anche a soggetti del nostro allevamento
L’amazzone elvetica ha vinto oggi il Gran Premio in Spagna, gara che ha visto protagonista il cavaliere azzurro: entrambi in sella anche a soggetti del nostro allevamento
‘Gli amici degli amici sono anche nostri amici’, un detto che in questo caso vale due volte: perché a presentarci Guillaume Henry* è stato Giovanni Battista Tomassini, che da tempo arricchisce le nostre pagine con i suoi articoli su storia e cultura equestre.
Ed entrambi sono amici dei cavalli, di quel mondo speciale che si riescono a creare attorno quando gli uomini che ne hanno la responsabilità non abdicano ai doveri nei loro confronti: che è poi il mondo che amiamo noi di Cavallo Magazine.
Che siamo lieti di condividere con voi, cari amici lettori, il primo articolo di due che Henry ci ha inviato: buona lettura!
Troppo spesso si riduce l’equitazione a un semplice divertimento o a uno sport competitivo. Eppure, il suo radicamento storico, le sue ricadute economiche e il suo ruolo educativo e sociale mostrano che la pratica equestre non è soltanto una questione individuale: montare a cavallo è un progetto di società, uno specchio del rapporto che intratteniamo con il vivente e una leva di trasformazione per i nostri territori, dunque per il nostro futuro.
Una pratica iscritta nella storia e nell’immaginario collettivo
Dalla sua domesticazione, intorno al 3500 a.C., il cavallo ha sconvolto il nostro modo di vivere.
Ha reso possibili i grandi spostamenti, le conquiste, la circolazione delle idee e delle culture.
Cavalieri e cavalli hanno costruito la storia umana. Senza il cavallo, niente espansione degli imperi, niente reti commerciali tanto estese, niente rapida diffusione delle innovazioni. È stato presente nel cuore dell’economia, dei conflitti, ma anche dell’immaginario di libertà.
Al di là dell’utilità pratica, il cavallo è stato a lungo associato alla potenza, alla nobiltà e al sacro.
Nelle mitologie greche e celtiche è legato agli dèi e alla luce. Nella cultura cavalleresca medievale incarna il coraggio, la fedeltà e lo slancio spirituale. I racconti epici – dall’Iliade alle chansons de geste – lo presentano come il compagno inseparabile dell’eroe.
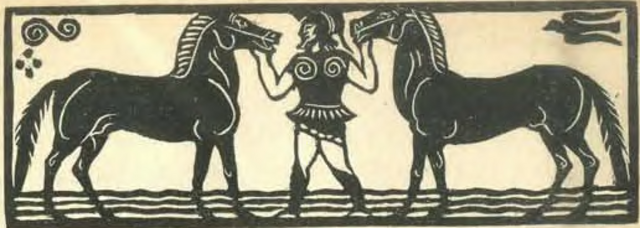
Immagine dall’Iliade nella traduzione Romagnoli, 1923
Così incarna, nell’immaginario collettivo, l’immagine di un animale che eleva l’uomo, che lo conduce più lontano, più veloce, ma soprattutto più in alto.
In Francia, come nel resto d’Europa, l’equitazione è intimamente legata alla storia politica, militare e culturale. I re di Francia, fondando i loro allevamenti e sviluppando le scuole di cavalleria, hanno fatto dell’arte equestre una vera e propria istituzione. Il Cadre Noir, come i circoli, sono oggi gli eredi di una lunga tradizione, ormai iscritta nel patrimonio culturale immateriale dell’umanità presso l’Unesco.
In ogni regione, il cavallo ha anche plasmato i paesaggi e i saperi: cavalli da tiro per i lavori nei campi, Camargue o Mérens come compagni nel mondo agricolo, corse e feste equestri come espressioni popolari.
Nel corso del XX secolo i cavalli hanno progressivamente lasciato le nostre campagne, le nostre città e i nostri eserciti. Alcuni hanno temuto che sarebbero scomparsi, ma non è stato così. L’uso del cavallo si è reinventato negli sport equestri, nelle attività del tempo libero, nel turismo e nella mediazione relazionale, educativa o terapeutica. L’equitazione è, oggi, un’eredità ri-orientata: l’eredità di una relazione millenaria reinventata in un contesto moderno, dove il cavallo non è più uno strumento, ma un partner.
Una sfida educativa e civica
Più che uno sport o un passatempo, la pratica dell’equitazione rimane una vera e propria scuola di vita. Innanzitutto, rende responsabili.
Prima ancora di montare, il cavaliere deve strigliare, curare e preparare la sua cavalcatura.
Impara l’importanza della cura e dell’attenzione verso l’altro. Bambino, giovane o adulto capiscono rapidamente che il successo non dipende solo dalla propria energia, ma dalla qualità della relazione instaurata con il cavallo.
Montare a cavallo significa anche imparare a rispettare e a collaborare.
A differenza di altre pratiche che richiedono di imporre la propria volontà, l’equitazione esige di entrare in un dialogo permanente con un essere sensibile che percepisce ogni gesto, ogni intenzione e persino ogni stato emotivo.
Il cavaliere deve quindi esercitarsi all’ascolto, alla pazienza e all’umiltà.

Più cerca di imporsi, più il cavallo si chiude. È adattando il proprio atteggiamento, proponendo piuttosto che costringendo, insomma, controllando prima di tutto se stesso, che ottiene la complicità del suo compagno.
L’equitazione è quindi anche una scuola di fiducia in se stessi. Il cavallo coglie e riflette immediatamente le emozioni di chi lo monta.
Il cavaliere deve imparare a gestire le proprie emozioni, a centrarsi e a mantenere la propria calma interiore per guidare correttamente la sua cavalcatura.
Il bambino timido accresce la propria sicurezza, il giovane impetuoso impara a canalizzare la propria energia – come già all’epoca di Senofonte, quando gli adolescenti più turbolenti venivano messi a cavallo per imparare a calmarsi –, e l’adulto comprende che la vera leadership si fonda sul controllo e sull’equilibrio, non sull’autorità brutale.
Si tratta anche di una pedagogia attiva, che funziona attraverso l’esperienza e la sensazione invece che attraverso l’accumulo di saperi teorici.
Il cavaliere impara facendo, percependo la risposta del cavallo e adattando i propri gesti. Questo modo di apprendere mette in risalto l’esperienza diretta come veicolo di progresso.
La pratica dell’equitazione sviluppa non solo l’attenzione e l’adattamento, ma anche una forma di intuizione e di responsabilità condivisa. Il «corpo che si è» è viene interamente coinvolto.
La pratica dell’equitazione è un apprendimento globale che forma individui responsabili, rispettosi e sicuri di sé, capaci di cooperare e attenti al loro ambiente. In questo senso, è una vera scuola civica e prepara le generazioni future a vivere in un mondo in cui il rispetto del vivente diventa una competenza essenziale.
Un attore del legame sociale e territoriale
L’equitazione permette anche di sperimentare il legame sociale, poiché i circoli e le scuderie riuniscono persone di età, origini, culture e condizioni sociali molto diverse.
Il bambino condivide l’apprendimento con l’adolescente, l’adulto dilettante con il concorrente esperto, l’abitante della città con quello della campagna. Qui, la diversità è una ricchezza, perché ciò che unisce gli individui è la loro passione comune per il cavallo.
Questa dimensione intergenerazionale favorisce la trasmissione di saperi e di valori, creando al tempo stesso un senso di appartenenza a una comunità coesa.
La pratica equestre ha anche una dimensione inclusiva.
Si apre a pubblici diversi, in particolare grazie allo sviluppo dell’equitazione adattata e terapeutica. Il cavallo è un mediatore eccezionale, capace di ridare fiducia a molte persone con disabilità, di stimolare l’autonomia e di offrire uno spazio di relazione diverso da quello proposto nei contesti sociali abituali.

Al di là del legame umano, l’equitazione partecipa alla vitalità dei territori. In molte zone rurali, allevamenti, scuderie e centri ippici contribuiscono a mantenere un’attività economica non delocalizzabile.
Creano posti di lavoro diretti – istruttori, palafrenieri, allevatori, veterinari – ma anche indiretti, legati all’agricoltura, al turismo e ai servizi. Il cavallo è un attore economico strutturante, capace di sostenere la vita locale.
La dimensione territoriale si traduce anche nella valorizzazione dei paesaggi.
I percorsi di escursionismo a cavallo, gli itinerari di turismo equestre o le feste equestri contribuiscono attivamente all’animazione culturale e turistica di molte regioni.
Attirano visitatori, sviluppano offerte di accoglienza e favoriscono la scoperta di patrimoni locali, siano essi villaggi, castelli o tradizioni viventi. In questo senso, il cavallo è un vettore di visibilità per i territori, che collega memoria storica e dinamismo contemporaneo.
L’equitazione costituisce così una sorta di «ponte» tra gli individui e i territori. Crea nuove forme di socialità, favorisce l’inclusione, sostiene l’economia rurale e valorizza i paesaggi. In una parola, restituisce senso e bellezza tra l’uomo, il luogo in cui vive e il tessuto collettivo di cui fa parte.
(*) Istruttore d’equitazione formatosi a Saumur, scrittore, divulgatore ed editore, Guillaume Henry è presidente della Mission Française pour la Culture Équestre, l’organismo creato dalla Federazione Equestre Francese e dal Cadre Noir, per promuovere lo sviluppo della cultura equestre di tradizione francese, inscritta nel patrimonio Unesco nel 2011. È autore di numerosi articoli sulla tecnica e la storia dell’equitazione, così come di una ventina di libri dedicati all’arte equestre, tra i quali François Baucher. L’uomo, il metodo (illustrazioni di Marine Oussedik), edito in Italia da More than a Horse.
(continua)
Guillaume Henry

























