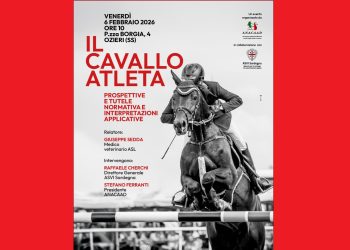Vigili del Fuoco e Protezione Civile soccorrono gli allevatori di Niscemi. Salvi i cavalli e gli asini isolati sul margine della frana ma l'emergenza non è finita
Vigili del Fuoco e Protezione Civile soccorrono gli allevatori di Niscemi. Salvi i cavalli e gli asini isolati sul margine della frana ma l'emergenza non è finita
All’alba, la steppa mongola non ha bisogno di creare atmosfera. Mostra ciò che è: un vasto piano di erba rada, aria secca, ombre di colline lontane e luce ancora giovane. È qui che prende forma, i primi di agosto di ogni anno, il Mongol Derby, la corsa a cavallo più lunga del mondo. Mille chilometri attraverso quei territori dove un tempo correvano i messaggeri di Genghis Khan, su cavalli semi-selvatici e in totale autonomia. Una gara che non promette gloria immediata, ma chiede capacità di adattamento. Non si tratta solo di resistere: si tratta di imparare a stare in un ambiente che non si piega.
Il regolamento è essenziale: niente fronzoli, solo un tracciato da seguire (che ogni anno cambia in base ai cambiamenti del territorio), stazioni veterinarie e punti di controllo. Tutto il resto appartiene alla Mongolia. Qui nasce il concetto che l’organizzazione definisce: Ride to Survive: non una frase d’effetto, ma la definizione pratica di come si affronta questa prova. Non è una competizione di equitazione tradizionale, ma un esercizio di orientamento, resistenza, lucidità e ascolto. Chi arriva pensando di “domare” la steppa scopre presto che la steppa non è interessata alla sopravvivenza dell’uomo.
Prima della partenza, i partecipanti attraversano il pre-race training, un periodo di preparazione che ha più a che fare con l’orientamento mentale che con la tecnica equestre. Si impara a leggere una bussola e un GPS, a sellare secondo gli standard locali, a gestire cavalli che non conoscono scuderie né routine di box. Ci si abitua al fatto che un cavallo mongolo decide il passo a modo suo, e che forzarlo è inutile. È una lezione che arriva in fretta: chi non l’apprende rischia di fermarsi ancora prima di iniziare.
Ogni 40 chilometri una stazione veterinaria, e ogni volta un nuovo cavallo. Il battito e la condizione generale del cavallo vengono controllati: il rispetto per l’animale è norma inderogabile. Se il cavallo recupera male, il tempo si ferma, le penalità iniziano, e la gara cambia volto. Qui l’abilità non è “spingere”, ma saper misurare. Emma Smith, amazzone britannica che ha completato la gara, ha raccontato che il primo ostacolo è stato smettere di pensare come in modo europeo: “Capisci che questo non è un cavallo addestrato a seguire te. Sei tu a dover seguire lui nell’ambiente che conosce.”
Il terreno non è ostile per scelta: è semplicemente sé stesso. Distese che sembrano lisce e improvvisamente cedono in buche profonde, fiumi tranquilli al mattino che crescono al pomeriggio, vento che a volte accompagna e a volte spinge via. I cavalli non temono nulla di tutto questo: ci sono nati. Il cavaliere, invece, impara ogni giorno qualcosa di nuovo, soprattutto sul proprio limite. Non è raro fermarsi presso famiglie nomadi, accettare un giaciglio, un piatto caldo, condividere poche parole, molta gestualità e un senso di ospitalità ineguagliabile, in quanto, letteralmente, vitale.
La vittoria di Bob Long, settant’anni, nel 2019, è spesso citata non come gesto eccezionale ma come dimostrazione di un principio semplice: qui non prevale chi è più forte, ma chi capisce il ritmo. La Mongolia non premia l’agonismo puro; premia la capacità di ascoltare, calcolare, osservare e ricalibrare. È una gara che insegna più con l’aria e la terra che con la tecnica e la voglia di vincere a ogni costo. Le storie dei partecipanti hanno un filo comune: si parte con l’idea di affrontare una competizione, si finisce rendendosi conto di avere condiviso un frammento di vita con cavalli che appartengono a questo territorio. La fatica rimane nelle ossa, il vento nelle orecchie, e una forma diversa di rispetto si insinua nelle abitudini. Mille chilometri più tardi, quello che si ottiene non è un traguardo da raccontare con enfasi, ma una consapevolezza concreta: in alcuni luoghi del mondo il cavallo non segue, guida. E tu, se vuoi veramente attraversare quella terra, devi imparare da loro ed essergli riconoscente perché, in certo luoghi, la vita non è scontata.